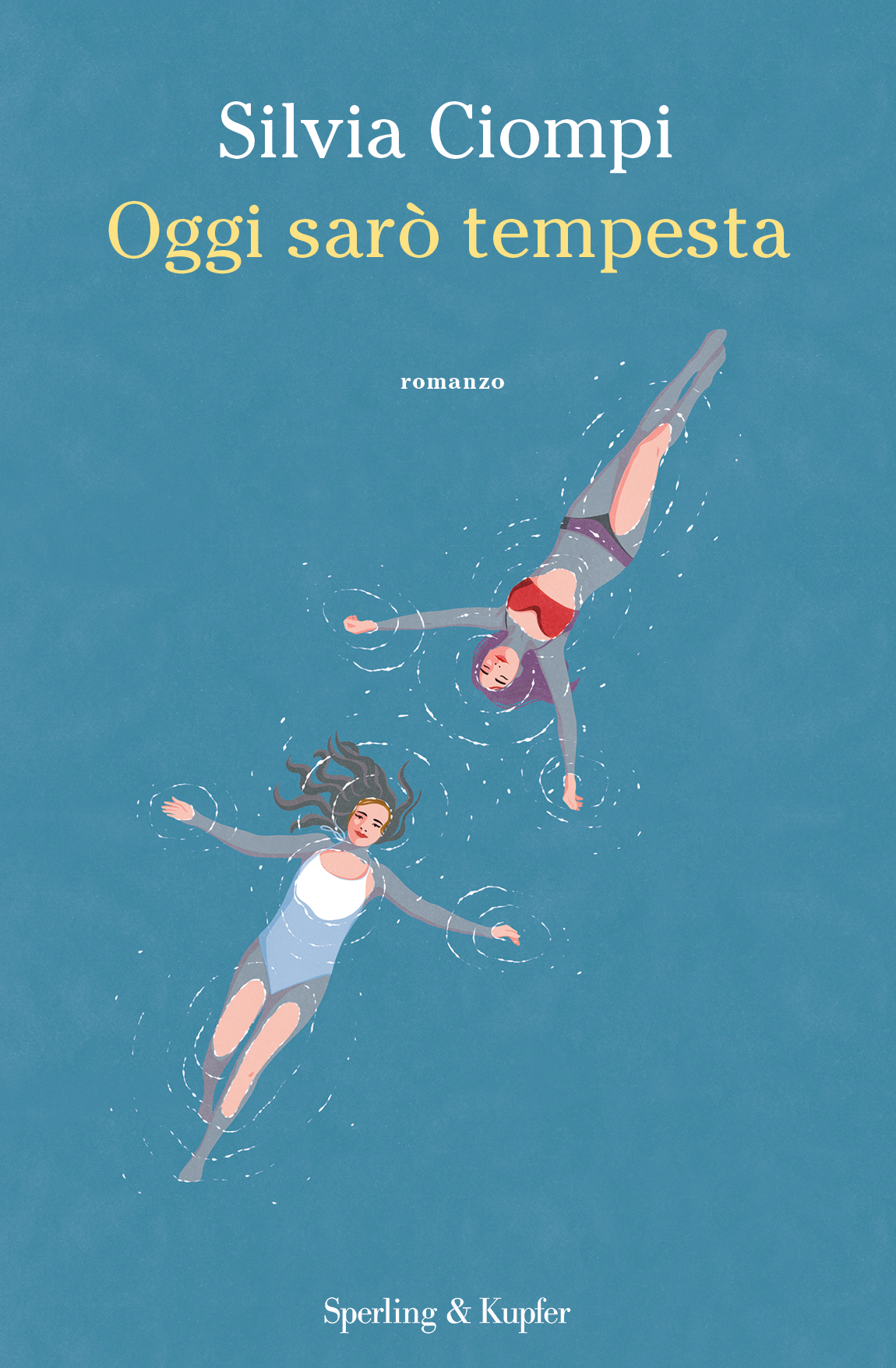(di Mimma Zuffi)

All’epoca
della composizione della Tosca, Giacomo Puccini era un compositore estremamente
celebre non solo in Italia. Aveva superato i quarant’anni e con due opere, Manon Lescaut (1893) e Bohème (1896), aveva colto
un clamoroso successo internazionale di pubblico e di critica. Pur non
negandogli il talento, una parte della critica rimproverava al musicista
lucchese una predilezione per soggetti
non altrettanto “alti” quanto quelli di Verdi e di Wagner. Per costoro, Puccini
era il cantore dell’anima femminile, il poeta della fragilità muliebre di
Manon, di Mimì, di Musetta, il musicista di un’umanità quotidiana, priva di
nobili ideali, dedita alle ”piccole cose”. Rendendosi conto dei rischi che
avrebbe corso restando prigioniero di
un cliché siffatto, da tempo si guardava intorno in cerca di uno spunto
librettistico diverso, nella forma e nella sostanza, da quelli fin lì musicati
(peraltro anche in mezzo a mille tribolazioni, ripensamenti, ritocchi). Puccini
aveva cominciato a pensare di ricavare un’opera da TOSCA, dramma in prosa di
Victorien Sardou, fin da quando lavorava all’Edgar, probabilmente dietro
consiglio di Ferdinando Fontana, librettista delle sue due prime opere. Sardou
era a quell’epoca un autore di gran moda. Andata in scena per la prima volta il
24 novembre 1887 a Parigi al Théatre de la Porte-Saint-Martin la Tosca di Sardou aveva colto un formidabile
successo sia per gli effetti “granguignoleschi” sia per l’interpretazione di
Sarah Bernhardt, tragédienne capace di ipnotizzare le folle con la sua dizione
esaltata e la sua gestualità grandiosa.
La Bernhardt venne in tournée in Italia con quel nuovo spettacolo all’inizio
del 1889. Puccini sedette fra gli spettatori a una replica al Teatro dei
Filodrammatici di Milano e, sebbene masticasse solo poche parole di francese,
restò colpito dall’efficacia del soggetto e dalle spettacolarità delle scene
madri. La lettera inviata al suo editore, Giulio Ricordi, perché si
interessasse all’acquisto dei diritti del lavoro di Sardou, porta la data del 7
maggio 1889 e rivela lo stato d’animo di Puccini a due settimane dal fiasco
dell’Edgar alla Scala: “ Mi accorgo che la volontà di lavorare invece
d’essersene andata, ritorna più gagliarda di prima (…) penso alla Tosca! La
scongiuro di far le pratiche necessarie per ottenere il permesso da Sardou,
prima di abbandonare l’idea, cosa che mi dorrebbe moltissimo, poiché in questa
“Tosca” vedo l’opera che ci vuole per me.” Alla fine del 1893 dovette mettersi
il cuore il pace poiché Casa Ricordi riuscì a strappare finalmente
l’autorizzazione di Sardou ma a favore di un collega, Alberto Franchetti.